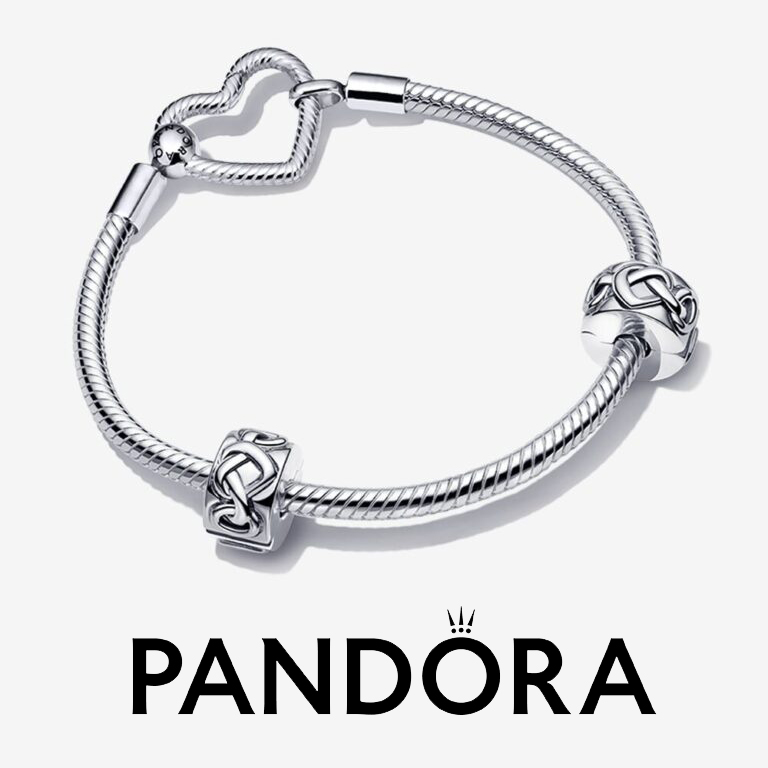Da poco è stata inaugurata, il 4 luglio scorso, ad Arezzo la mostra antologica dedicata a
Marino Marini e curata da Alberto Fiz e Moira Chiavarini, con il coordinamento scientifico
di Alessandro Sarteanesi.
L’esposizione, che rimarrà aperta fino al 2 novembre prossimo, rappresenta un viaggio
ricco di emozioni nell’universo dell’artista pistoiese (1901-1980), capace di cogliere la
centralità e l’essenza dell’inquietudine umana, trasformandola in sculture e pitture
straordinariamente potenti.
La mostra è prodotta e organizzata dal Comune di Arezzo, dalla Fondazione Guido
d’Arezzo, si è avvalsa della mediapartnership della Nazione ed è stata progettata
dall’associazione culturale Le Nuove Stanze e Magonza.
Dopo la personale dedicata ad Afro Basaldella, prosegue ad Arezzo l’indagine sul
Novecento italiano con Marino Marini in una mostra antologica che prevede due percorsi
che si integrano a vicenda. Il primo è alla Galleria Comunale d’Arte Moderna e
Contemporanea, con una serie di dipinti, gessi e bronzi; la seconda alla Fortezza Medicea
con grandi sculture e opere monumentali.
L’esposizione alla Galleria Comunale rivela con forza l’emergere della relazione con
l’antico. Infatti già la posizione della Galleria ne è giustificazione. La Galleria è situata al
fianco della Chiesa di San Francesco, che custodisce il ciclo di affreschi delle Storie della
Vera Croce di Piero della Francesca. Significativo il rapporto tra le figure rappresentate da
Marino , tra cui le opere intitolate “Le vergini” del 1916 e la “Zuffa dei cavalieri” del1927,
quest’ultima concessa dagli Uffizi, che evocano lo stile di Piero della Francesca.
Per la prima volta sono anche presenti, accanto alle sculture di Marino, alcune sculture
ellenistiche in terracotta rinvenute durante gli scavi della Catona ad Arezzo e che l’artista
vide pubblicate sulla rivista ‘Dedalo’ nel 1920, diretta da Ugo Ojetti, una delle più rilevanti
pubblicazioni di critica d’arte dell’epoca, sculture provenienti dal Museo Archeologico
Nazionale Gaio Clinio Mecenate.
Il secondo percorso si snoda negli ambienti della Fortezza Medicea, dove le opere e
sculture monumentali di Marini vengono accolte in una scenografia imponente. Vi si
possono ammirare le “Pomone”, simbolo di fecondità, “I giocolieri” e i celebri “Cavalieri”,
tra i quali spicca “Il grande cavaliere” del 1949-50, opera che esprime la continua indagine
dell’artista sul rapporto tra uomo e destino.
Pittura e scultura sviluppano una relazione dialettica e questo avviene nell’accostamento
tra “Studio per Miracolo”, un capolavoro plastico risalente agli anni 1953-54, e “Orfeo”, un
dipinto che si sviluppa sulla medesima matrice lirico poetica. “Miracolo” è il titolo di una
scultura imponente in bronzo risalente al 1952 dove “l’idea parte fino a distruggersi” e la
scultura “vuole andare in cielo, vuole bucare la crosta terrestre o vuole, addirittura, andare
nella stratosfera” come ebbe dichiarare lo stesso Marino.
Le due componenti bidimensionale e tridimensionale trovano la loro convergenza nella
sala dei Gridi , come in quella delle Pomone.
Marino Marini si è anche dedicato al teatro, basti pensare all’opera intitolata “Il giocoliere”
del 1939. Un suo altro ambito di ricerca rimane il ritratto di cui ne ha realizzati circa 150,
tra cui gli omaggi a De Pisis, Carlo Carrà, Massimo Campigli, Marc Chagall, Jean Arp,
Germaine Richier, Igor Stravinsky e Marina, sua compagna di vita e sua Musa.
“Pochi artisti hanno sentito così profondamente come Marino Marini il senso delle proprie
radici – spiega Silvia Evangelisti, consigliere di amministrazione del Museo Marino Marini
di Firenze – e pochi come lui hanno saputo esprimere modernamente il sentimento della
classicità. La terra natia di Marino Marini è la Toscana, patria antica del popolo etrusco
della cui grande cultura e civiltà artistica conserva, ancora oggi, le preziose testimonianze
e a quella grande tradizione artistica si rivolge Marino Marini per cogliere il fascino di una
pienezza formale, limpida e pagana, arcana, profondamente umana, priva di ogni retorica
e arcaismo letterario. Nelle Pomone, nei ritratti, nei Giocolieri, nei Gruppi equestri di
‘Cavallo e cavaliere’ di questo artista, nelle sculture, disegni o dipinti, il sentire classico si
traduce in profonda armonia di forme, in perfetto equilibrio tra le parti e in una grande
semplicità in nome della quale egli sacrifica ogni dettaglio narrativo”.