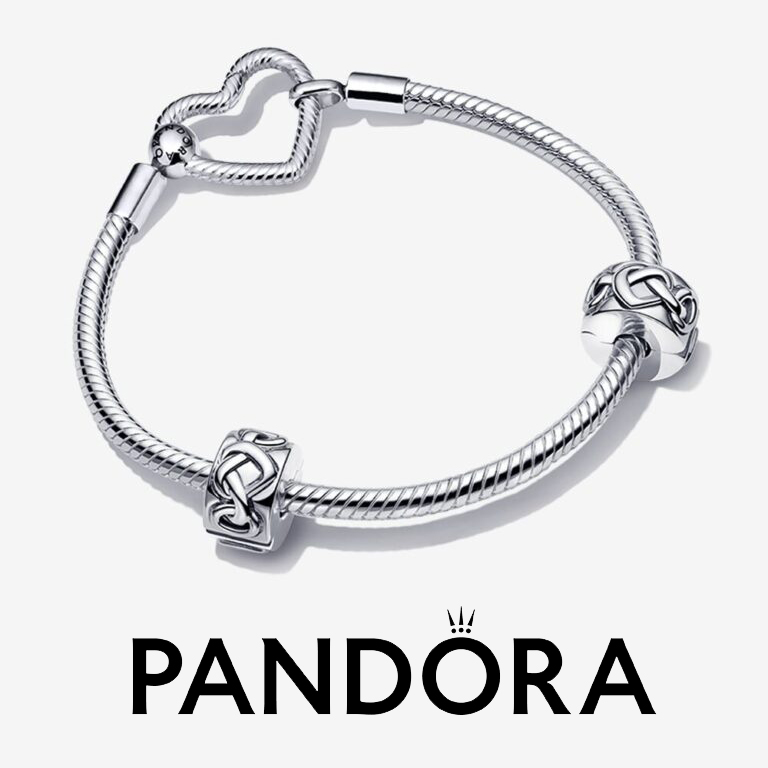Siamo in compagnia di Enzo Gerbi, Direttore della Cantina Barbera dei Sei Castelli, figura di riferimento nella valorizzazione della Barbera d’Asti e persona che ha dedicato gran parte della sua vita a questo vitigno, da lui definito a ragione “unico”.
Direttore, quando ha avuto inizio il suo percorso nel mondo del vino?
Ero ancora un ragazzo. Si può dire che sono nato tra i filari di Barbera: i miei genitori erano produttori e ho vissuto immerso nel territorio e in questo vitigno che mi ha accompagnato fin dai tempi della scuola enologica. Era l’inizio degli anni Ottanta, un periodo di trasformazione profonda nel modo di intendere il vino, quando si cominciava a parlare seriamente di qualità.
Ho maturato le prime esperienze in aziende private, poi nel 1989 sono entrato nel mondo della cooperazione ad Agliano Terme come enologo. All’epoca esistevano tre cantine, nate negli anni Sessanta, che nel 1996 furono unite grazie alla lungimiranza degli amministratori. Da questa sinergia è nata la Cantina Barbera Sei Castelli, oggi il maggiore produttore di Barbera d’Asti. Ritengo di essere l’enologo che ha vinificato la maggiore quantità di Barbera d’Asti nella sua carriera: stimiamo oltre un milione e mezzo di quintali d’uva. Dal 1997, inoltre, dirigo l’intera azienda.
Tanti anni di lavoro in un settore profondamente cambiato. Come ha visto evolvere la Barbera in questo tempo?
L’evoluzione qualitativa è stata straordinaria. La Barbera ha rivelato un potenziale incredibile e una versatilità notevole. Un tempo era un vitigno orientato alla grande produzione: si puntava alla quantità, vista la sua resistenza e adattabilità a diversi suoli e climi, soprattutto nel periodo post-fillossera. Era una varietà che garantiva rendimento.
Ma la Barbera custodisce caratteristiche uniche che, con una gestione viticola attenta, permettono di ottenere vini dalla forte identità: da quelli di pronta beva a quelli capaci di evolvere con eleganza nel tempo. Una settimana fa, insieme ai miei collaboratori, abbiamo condotto una degustazione verticale dal 2007 al 2022, una vera dimostrazione delle potenzialità espressive del vitigno, anche in ottica internazionale, per struttura ed eleganza, qualità rare in altri vitigni.
Parlava della fillossera: che impatto ha avuto sulla Barbera e sul territorio?
La fillossera ha causato l’estinzione di molti vitigni, ma la Barbera ha resistito. Ha subito perdite, certo, ma è sopravvissuta, dimostrando la sua resilienza. Tuttavia, tra il 2009 e il 2010, abbiamo notato, insieme al mio collaboratore Salvatore Giacoppo, che alcune vigne ultracentenarie stavano scomparendo: erano ceppi piantati nel primo dopoguerra, ormai al termine del loro ciclo vitale.
Abbiamo così deciso di recuperare quel patrimonio genetico. Non volevamo creare un nuovo vino, ma salvaguardare qualcosa di unico, autentico, da trasmettere alle generazioni future.
Ed è nato un progetto scientifico. Come si è sviluppato?
Abbiamo avviato una collaborazione con l’Università di Torino. Dopo aver selezionato in vigneto 34 ceppi con caratteristiche particolari, li abbiamo moltiplicati e sottoposti a una prima analisi scientifica. Da lì, abbiamo individuato nove individui promettenti dal punto di vista agronomico.
A quel punto, abbiamo avviato microvinificazioni per verificarne il potenziale enologico. Dopo tre anni di studi e degustazioni con l’università, sono emersi quattro ceppi eccezionali, sia per le caratteristiche in vigna sia per quelle in cantina. È stato l’inizio di un nuovo orizzonte.
Il progetto ha assunto anche una dimensione artistica e culturale?
Sì, questi ceppi non rappresentano solo un recupero tecnico. Un grappolo, un vino, sono anche espressione di storia, arte, identità territoriale. Abbiamo così unito il nostro lavoro con quello artistico di Ezio Ferraris, che aveva ridato vita a ceppi coevi già estirpati, creando un ponte tra passato e presente.
Nasce così il progetto “Il Risveglio del Ceppo”, che evoca una rinascita produttiva: le nuove viti conservano il patrimonio genetico originario, senza introdurre cloni o innesti esterni. È un progetto di sostenibilità e memoria viva.
Quindi un’iniziativa che è al tempo stesso artistica, culturale, storica e agricola?
Esattamente. Il “Risveglio del Ceppo” è racconto e testimonianza di un’epoca che ha forgiato questo territorio. È stato determinante l’incontro con Monica Meneghelli, che ha saputo unire il mondo tecnico con quello artistico e culturale, dando coerenza a visioni differenti. L’incontro tra Ferraris, Meneghelli, me stesso e i ceppi storici ha dato vita a qualcosa di nuovo, aperto anche al mondo esterno, superando una visione tradizionalmente chiusa.
Ed è nato anche un luogo fisico che racconta tutto questo.
Sì, un vero e proprio centro turistico: non solo degustazioni, ma anche un museo, “L’Anima del Vino”, che offre ai visitatori – anche a chi non è appassionato di vino – un’esperienza diversa, emozionale, artistica. I ceppi esposti hanno forme irripetibili, figlie di una viticoltura di inizio Novecento che non può essere replicata.
Un’iniziativa che tocca anche il tema della valorizzazione del territorio.
Assolutamente. Il nostro obiettivo era lasciare alle generazioni future qualcosa di autentico, che andasse oltre la standardizzazione. Il vino è parte di un ecosistema più ampio fatto di fatica, lavoro, memoria, e contribuisce alla cura e alla salvaguardia del paesaggio. Dove si abbandona la coltivazione, emergono i problemi. Coltivare significa custodire.
E così siete anche parte attiva in un settore in crescita come quello del turismo.
Esatto. La nostra visione ha voluto unire vino, arte e cultura in un progetto turistico completo. Il centro “Risveglio del Ceppo” accoglie i visitatori offrendo molto più di una semplice degustazione: è un luogo in cui l’enoturismo si fonde con l’identità artistica e storica del territorio, creando un’esperienza immersiva e irripetibile.